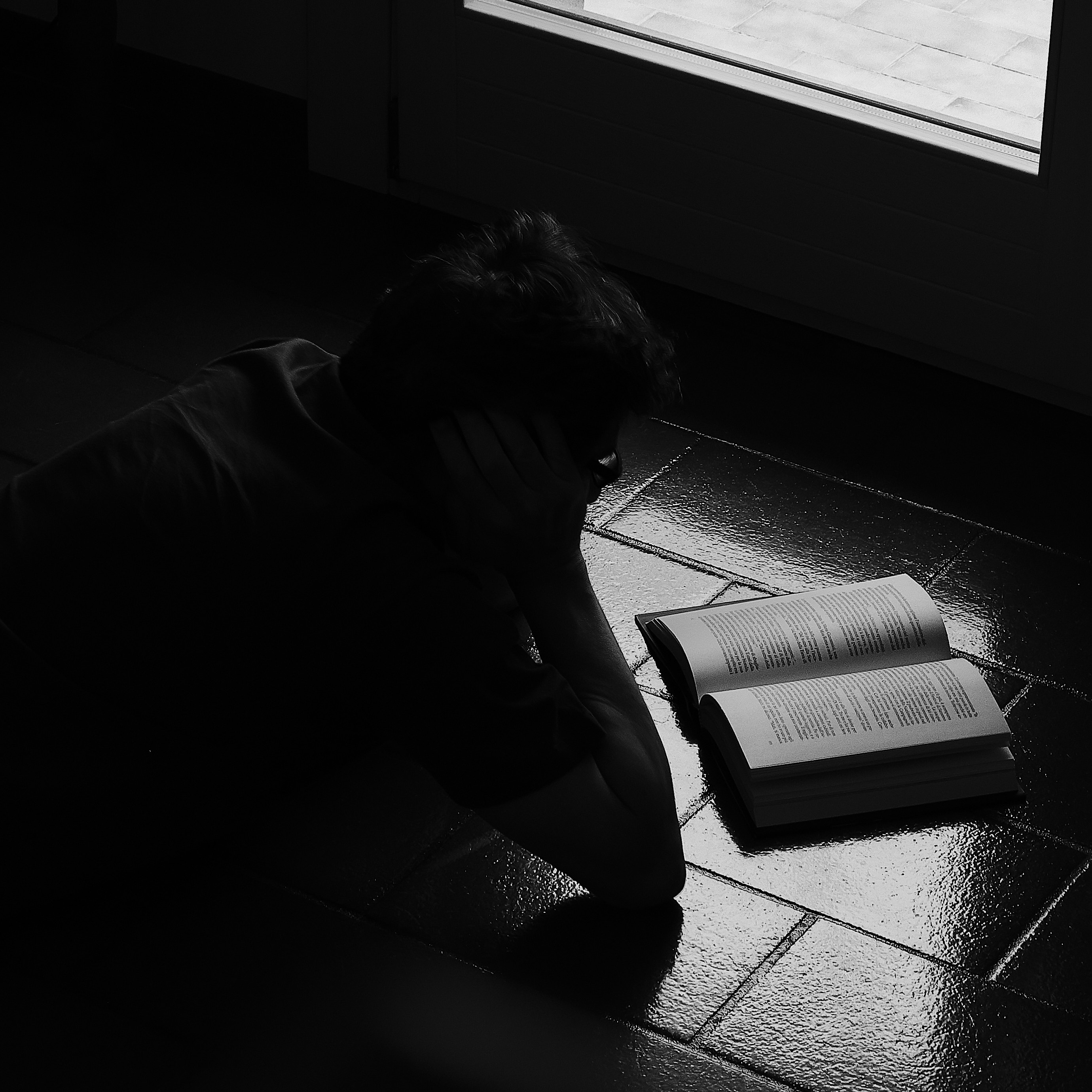Sono rimasto sveglio fino a notte fonda, incollato al computer a guardarmi tutte le puntate del video di un tale che insegna a pilotare un B737; osservando Harry, mi viene il vago sospetto che abbia imparato il mestiere in questo modo. C’è, in effetti, una bella differenza, nel percorso che ci ha portato a sederci, fianco a fianco, nel cockpit di questo A320. La più significativa e che lui, o chi per lui, ha dovuto sborsare circa 120.000 Euro mentre io, non ho speso nemmeno una di quelle che erano le vecchie lire; anzi, sin dall’inizio, sono stato pagato. Poca roba, la paghetta, da najone che, l’Aeronautica mi elargiva nei primi periodi di Accademia, riuscivo a malapena a farmi venir fuori quattro pizze al mese, due per me e due da offrire, tanto per fare el sgandesson, alle indigene del posto che, ci facevano compagnia nelle rare libere uscite. Ad Harry, la pizza gliela pago sempre io; ‘sto ciccionetto occhialuto, ne va ghiotto; andrà a finire che non riuscirà più a entrare in cabina e del suo EASA Class1 Medical, ne faranno pezzettini.
Quando l’ho visto per la prima volta, non ho creduto ai miei occhi, Harry Bernard Charles, il suo nome sforava lo spazio disponibile sul badge, quello che però mi fece cadere letteralmente le palle, era la data di nascita, 14/08/1996. Probabilmente si era appiccicato l’aquila sul taschino e la striscia sulla manica, direttamente sulla divisa che usava al college. Quello che, alla fine è diventato, el me fio de anema, come diciamo noi in volgo, sembrava essere uscito da un film di Harry Potter. Avevo sentito parlare del nuovo programma di addestramento della compagnia per formare giovani piloti ab initio o cadet pilot come li chiamano loro ma, che un giorno, mi sarei trovato di fronte un ragazzino con la pretesa di farmi da primo ufficiale, non l’avrei lontanamente immaginato.
Crew Resource Management, tradotto in parole povere significa, “te lo trovo io quello giusto per pilotare insieme a te”; avessero adottato ‘sto sistema in Aeronautica, non mi sarei trovato un imbecille, seduto sul seggiolino posteriore, a causa del quale, ci mancò poco che dovessimo eiettarci in pieno territorio bosniaco, con quelli di sotto pronti a farne ea succa; vagli a spiegare che dovevamo solo fare delle foto. Io e el bocia inglese, invece, ci intendemmo subito. Non posso negare che quel rosso dal faccione tondo mi fece tenerezza; vidi subito in lui quel genere di figlio che avevo sempre desiderato.
Il discreto “piccolo lord” che, ancora si rivolge a me, dandomi del “Sir”, è sempre stato incuriosito da mio trascorso aviatorio. Sbarrava gli occhi quando gli raccontavo del fortissimo “calcio in culo” che, L’F104, il mitico spillone, ti dava in fase di decollo. Non ho mancato, la meticolosa descrizione, di quella volta a Istrana quando, in atterraggio, ho rischiato di finire lungo e trovarmi in Postumia e, centrare in pieno con il tubo di Pitot, quella Panda azzurrina, della quale riuscii a distinguere perfettamente il vecchio con il cappello che la guidava. Anche se vedo il ragazzo divertito nell’ascoltarmi, la cosa mi rattrista, pensandoci bene, è come se a me un vecchio pilota della II^ guerra mondiale mi raccontasse delle sue avventure con lo SPITFIRE.
Un saggio, di cui non ricordo il nome, dice; “un uomo non è vecchio finché i rimpianti non sostituiscono i sogni”; la frase sembra si adatti alla perfezione a questa giornata. Oggi è il mio “Last flight”, ultimo volo e ultimo giorno di lavoro. “Non pensarci Gian, non puoi lasciar vagare la mente, devi stare concentrato fino al termine del volo“; una parola, mantener fede a questo proposito, ci sono riuscito in migliaia di ore di volo sia da militare che da civile, ma oggi no. Se ne deve essere accorto anche el bocia, la sua espressione è tra il preoccupato e l’imbarazzato; gli do una rassicurante gomitata sulla guancia che però, ha l’effetto di fargli quasi inghiottire il microfono.
Coraggio, la tratta Gatwick – Venezia potrei farla anche con un vecchio biplano Tiger Moth, a forza di guardar fuori dal finestrino, conosco a memoria tutti i punti di riferimento visivi; dopo il decollo dalla Runway 26L , virata a ridosso di Clarks Green, paralleli all’A24; la Leith Hill Tower alla mia destra mi ricorda i mitici pini marittimi dell’A4 che segnavano l’approssimarsi del casello di Padova Est. Posso chiudere gli occhi e, in base ai rumori attorno all’aereo, so esattamente quello che stanno facendo; ora chiudono il portellone bagagli C1, dentro ci sono due mie valigie.
Con ‘sta mascherina sulla bocca, le comunicazioni radio sono problematiche; non ho ricordo di avere avuto la stessa difficoltà ai bei tempi in Aeronautica, quando volavo tutto bardato, con addosso il casco e relativa maschera d’ossigeno.
“Ready for pushback”, ci siamo, mi spingono fuori per l’ultima volta, guardo la faccia del Ramp Agent, sembra che goda a farlo, quasi sapesse che non tornerò più; grazie alla mascherina, gli faccio uno sberleffo, tanto non vede. Anche nel 2001 mi hanno spinto fuori, dopo i 18 anni di ferma obbligatoria, sembrava quasi un reality televisivo, “tenente colonello Morotto, per lei l’Aeronautica finisce qui”. In realtà, i colleghi piloti di caccia, me l’hanno sempre detto; siamo come i calciatori di serie A, passati i trentacinque, non vali più niente; si tengono quei pochi rotti in culo raccomandati e li mettono a comandare, gli altri, in ufficio a smazzare carte, oppure, saluti e baci e via.
Gli ultimi mesi erano tutto un susseguirsi di proposte più o meno indecenti, a cominciare da certi misteriosi personaggi che cominciarono a contattarmi per telefono o, al circolo ufficiali. Si rivolgevano a me, molto spesso, avanzandomi di grado e quindi dandomi del colonello, come quelli che ti danno del dottore a prescindere, giusto per ruffianarsi. Non appena ti stringevano la mano, avevi la sensazione di essere davanti a un viscido serpente, mi parevano tutti dei Sir Biss usciti dal film “la spada nella roccia”. Rifiutai cortesemente tutte quelle, a dir poco, strane proposte e, come la maggior parte dei miei colleghi fuoriusciti, transitai nell’aviazione civile. Le compagnie aeree nascevano come funghi e senza difficoltà ne trovai una che mi promise mari, monti nonché soldi, come se piovesse. Il grassone, non mi ricordo che carica avesse; anche lui, dandomi, in successione i titoli di colonello, dottore e comandante, mi disse che dovevo formare gli equipaggi con la stessa severità dei militari. Mi ricordo invece il suo sigaro acceso nonostante il divieto e che rideva facendo ballare la pancia; di li a poco, comunque, per i noti fatti accaduti, avrebbe smesso di ridere, ma non di fumare.
Il 19 novembre 2001 me lo ricordo bene, il clima a Tolosa era alquanto deprimente, speravo che in aula entrasse qualcun altro; niente da fare ero l’unico mandolon, come diciamo noi, il più vecchio in assoluto nonché, l’unico europeo. Incontrai per la prima volta le nuove generazioni di piloti civili; ragazzi che, da una mia prima impressione, finora avevano visto gli aerei solo sulle figurine. Cinque di loro, in particolare, avevano delle facce poco raccomandabili, in compenso, parlavano francese in modo impeccabile; erano tre libici e due della Costa d’Avorio. Non arrivarono ad entrare nemmeno nel simulatore, vennero rispediti al mittente assieme ad un altro manipolo di presunti piloti; motivazione, imparare almeno i rudimenti del volo; “e che cavolo!”, dissi tra me e me, giustizia è fatta. Rimanemmo io, quattro cinesi, due indiani, tre russi e un canadese, proprio come nelle barzellette.
Eh già, il simulatore, altra bella botta, imparare a pilotare un aereo senza nemmeno staccare le ruote da terra. D’altronde, due mesi prima, un gruppetto di disgraziati, aveva mostrato a tutto il modo che ciò era possibile ma, quel che è peggio, avevano violentato il magico mondo dell’aviazione. Irrimediabilmente dissolto l’alone di romanticismo che avvolgeva noi aviatori, al quale, anch’io, fin da bambino credevo. Da quel giorno, grazie a loro, ce ne stiamo chiusi a chiave, barricati dentro la cabina di pilotaggio come degli appestati. Non possiamo più tenere aperta quella porticina, dalla quale, ogni tanto, si affacciava incantato, un bambino per chiedere come si fa a diventare pilota.
“Monsieur, non sia triste, è solo un corso di pilotaggio”. Antoine sapeva essere anche un po’ psicologo, la persona giusta che mi ci voleva in quel momento. Si esprimeva perfettamente in italiano, a tradirlo solo la classica erre moscia; a sentirmi chiamare monsieur mi pareva di essere un nobile e non gretto ex militare come qualcuno mi stava già definendo. Alto e magro come uno stuzzicadenti, aveva in testa la classica chierica di chi ha portato il casco per migliaia di ore di volo; il suo nome evocava Antoine de Saint-Exupéry ed era, come lui, un aviatore con la A maiuscola. Quando mi disse che era un ex pilota di Mirage; scattò in me la molla e gli chiesi, “ma allora tu eri un Chevaliers du ciel”. Mi riferivo alla mitica serie televisiva degli anni ’70, quella che contribuì ad alimentare in me la passione per il volo; ogni sabato, all’ora di pranzo, me ne stavo incollato davanti alla TV a sognare di pilotare un Mirage. “Je ne conduis pas, je vole” (io non guido, io piloto), replicò con la famosa frase del tenente Tanguy; Antoine, amicone mio!
Tolosa, grazie alla sua sapiente guida, acquistò di colpo splendore; ricordo le piacevoli passeggiate lungo le rive della Garonne e le soste nei locali di Rue des Filatiers. Alla fine, fu pure una passeggiata ottenere l’abilitazione all’Airbus A320. Antoine, quell’ultima sera che soggiornai a Tolosa mi invitò a casa sua, una bellissima villetta, fatalità, in rue Leonard de Vinci a Fonsegrives, un piccolo quartiere residenziale, nei pressi del minuscolo aeroporto di Lasbordes, sede del locale aeroclub, altra fatalità. Il suo grande studio, era pieno zeppo di modellini e moltissimi altri cimeli aeronautici; tornai di colpo bambino. C’era praticamente tutto quello che avevo pilotato; SF-260, MB-339, T-38, Tornado e il mitico F-104 che, affettuosamente, presi subito in mano. Antoine quasi non ci credeva che fossi stato uno degli ultimi fortunati a portarlo in volo, prima che venisse dismesso dall’Aeronautica, solo un vecchio pilota di Mirage, poteva capire, mentre passavo tra le dita la fusoliera del mitico “spillone”, tutta la mia tristezza. Mi stava prendendo un gran magone, una parte della mia vita, la mia giovinezza se ne era andata; niente più looping, tonneau, virate strette al massimo dei G, legato al seggiolino Martin Baker; ora sarei dovuto stare, comodamente seduto, ben vestito, davanti a una miriade di schermi LED e, portare a spasso per il cielo poco più di un centinaio di chiassosi gitanti; “c’est la vie, mon commandant”, il vecchio aviatore mi abbracciò forte.
Eh si, c’est la vie; troppe promesse, tante illusioni; me l’avevano detto che sarebbe stato così nel mondo dei “civili”. Sul Web, abbandonato come un messaggio in bottiglia in mezzo al mare, è rimasto ancora il mio curriculum, fermo a quel momento della mia vita nel quale, illusioni e promesse erano all’apice. La crisi, la continua ricerca di un posto di lavoro; non avrei mai pensato investisse anche me, un pilota non certo di primo pelo; costretto a emigrare addirittura nei paesi arabi, per portare a casa la pagnotta. Poi, per fortuna, arrivò un posto nel “vicino” regno di sua maestà che, alla fine, mi ha permesso, in questi ultimi anni, di tornare a volare sul cielo di Venezia; atterrare e decollare da quell’aeroporto dove, da ragazzi, passavamo intere giornate ad ammirare gli aerei.
Tra i miei “non avrei mai pensato; non avrei mai immaginato”, al vertice della classifica, almeno finora, è che un infinitesimamente piccolo virus, mettesse di colpo a terra quasi tutti gli aerei del mondo; costringendomi a rimanere per tutti quei mesi a casa, a fissare, stracolmo d’ansia, il cielo vuoto. Proprio io che ero stato addestrato a sopravvivere in tempo di guerra, mi son sentito di colpo perduto e fragile; la più grande paura, non era quella di ammalarmi ma, non sapere se avrei continuato a volare. Più il tempo passava, più il rischio di perdere le abilitazioni e la licenza di volo si faceva concreto; centinaia di telefonate e mail, non si muoveva nulla, non volava nulla.
Nei giorni del lockdown, contravvenendo alle regole, feci qualche kilometro in più in bici; il gioco valeva senz’altro la candela. Avevo più di una pendenza, diciamo, affettiva, nei confronti di un vecchio amico, in pratica, mi ero comportato da stronzo. “Fra quarant’anni esatti …”, mi ricordavo benissimo di quella promessa e dell’appuntamento. Ci sarei dovuto andare, se non altro, per rendere il giusto onore a Fabietto, visto che, non ero riuscito a sapere in tempo del suo ultimo volo. Quel giorno però, mi trovavo nel sud della Spagna coinvolto in un’appassionante fuga d’amore clandestina; questione di priorità.
“Peso de quando gerimo fioi nei anni ’70, ne ‘rivarà soeo do o tre al giorno”; seduti sulla mitica panchina in riva al canale che porta alla darsena dell’aeroporto, io e Tiziano, scrutavamo sconsolati l’orizzonte. L’unica cosa positiva era che il tratto di laguna antistante la testata pista, si era ripopolato i uccelli migratori delle più svariate specie;
“Me vien da butarme dentro l’Osein”
“Va in cueo comandante; prima o poi, no so quando, ti riscomissierà a voar”
“Appunto, no so quando”
“Camina mona, so sicuro che ti ritorni a pilotar, scometo ‘na cassa de bira”
Ripresi, ma poco dopo venni convocato dall’austroungarico brizzolato, soprannominato dal nutrito gruppo di piloti italiani de Roma, “er merda”, nel senso che uno più stronzo di lui è difficile trovarlo. Pur sapendo benissimo chi ero, avrò contribuito a formare non so quanti piloti, non mi salutava e non mi cagava manco di striscio. Mi rivolse la parola solo per dirmi, “alla sua età comandante è giusto che si goda il meritato riposo”; gli risposi che quel, “alla sua età”, mi sembrava fosse arrivato troppo presto; senza salutarlo, girai i tacchi.
“Cleared for takeoff”, la mezzeria della pista comincia a scorrere sempre più rapidamente; in tutti questi anni, specie in Aeronautica, ho imparato a pensare rapidamente e, a più cose contemporaneamente; un mio istruttore diceva, “non lasciate mai che l’aereo vi porti in un posto in cui il vostro cervello non sia arrivato almeno cinque minuti prima”. Mi concentro sul decollo, rispondo in sequenza ai check di Harry e, contemporaneamente, ripenso alle mie prime volte che affrontai da solo quella striscia di cemento.
Non so se quel figlio di buona donna di capitano istruttore del 70° di Latina, di cui ho stranamente dimenticato il nome; faceva lo stronzo solo con me o con tutti gli allievi, fatto sta che, quel giorno, dopo avermi per l’ennesima volta riempito di merda, per tutta la durata della missione di addestramento, mi rispinse a forza dentro l’abitacolo; “burba, togliti dai coglioni e vatti a fare un giro da solo”.
Pieno di rabbia, chiusi la cappottina, riaccesi il motore e puntai il muso del 260, diritto verso la pista. Volevo urlare per sfogarmi ma, avevo paura che mi sentissero per radio, per cui, strinsi con forza la cloche e diedi manetta, forse troppo violentemente, fatto sta, che decollai in quasi metà spazio. Una volta in volo, avrei voluto passargli rasente sulla sua testa pelata, ben visibile anche a 300 metri dal suolo. Solo quando, come da tradizione, mi buttarono dentro la piscina, realizzai che quello era stato il mio primo volo da solista; avevo conquistato l’agognato brevetto di pilota d’aeroplano; però, stranamente, questo non mi rese felice come mi sarei aspettato. Era successa la stessa cosa con Caterina; anni a sognare, con fiducia cieca e immutabile, quel giorno in cui avrei trovato il primo amore. Poi; quando finalmente arrivò il tanto atteso momento, ovvero la sera in cui ci mettemmo assieme; nessuna emozione, solo una eterna notte insonne, come dopo il mio primo volo da solista con il 260. Ore passate a rivoltarmi nel letto a chiedermi; “beh, tutto qua?”, non era come lo immaginavo; mistero, non riuscivo a capire, il perché non sprizzassi di felicità.
Diverso fu quell’agosto del 1988. Ci saranno stati cinquanta gradi nel piazzale della Sheppard Air Base eppure, un brivido di freddo mi percorse il corpo dalla testa ai piedi mentre Jeremy, il fido specialista, mi stava assicurando al sedile del mitico T-38 Talon. Erano passati appena sei mesi da quando, in Accademia, mi dissero che “avrei fatto l’americano”, ovvero che ero stato selezionato, assieme ad alcuni paricorso, per addestrarmi presso l’Euro-NATO Joint Jet Pilot Training di Sheppard, nel Texas. Stentavo a crederci; eppure, dopo pochi giorni, mi ritrovai seduto su un Jumbo che mi portava in America; ricordo pure di essermi messo a ridere mentre pensavo, che quella, era la prima volta che “prendevo” l’aereo, pur sapendone pilotare uno.
“Tenente, ora è tutto suo. D’ora in poi, faccia di tutto affinché il numero dei suoi atterraggi sia uguale al numero dei suoi decolli; buona fortuna”; Jeremy mi diede il cinque con la sua manona poi, gentilmente accompagnò la discesa del tettuccio. Continuavo a non crederci; io, ai comandi di quel bellissimo aereo che sognavo di pilotare, da quando, assieme a Fabietto, ne costruimmo il modellino, trasformando un vecchio kit Airfix del monoposto F5 Tiger, da cui derivava. Solo nell’abitacolo; percepivo chiaramente il mio respiro attraverso la maschera dell’ossigeno, feci il cenno convenuto a Jeremy che era tutto a posto, sbloccai il freno e mi avviai verso la pista; non era come a Latina, quella era la vera, emozionante, prima volta.
Un calcio in culo; questo è quello che senti quando decolli con quel tipo di aerei; in poco più di un minuto ti trovi a 35.000 piedi; di colpo ti cambia la prospettiva del mondo, non lo vedi più piatto. Prima di partire per la Sheppard, avevo fatto la stessa cosa con la mia vita sentimentale; troncando con Caterina. Un bel calcio in culo, a quel rapporto piatto, reso soffocante dalla sua indole possessiva; in fin dei conti, pensavo, non avevamo nemmeno la nostra canzone; brutto segno per me, che ho sempre avuto una canzone, per tutti i momenti importanti della mia vita.
Quando scesi dalla scaletta del T-38, invece “noi ragazzi di oggi”, risuonava dentro di me; me l’ero sparata a manetta con il walkman per caricarmi prima del briefing.
Noi, ragazzi di oggi, noi
Con tutto il mondo davanti a noi
Viviamo nel sogno di poi
Noi, siamo diversi ma tutti uguali
Abbiam bisogno di un paio d’ali
E stimoli eccezionali…
Avevo finalmente il mio paio d’ali, tornai in Italia fiero della mia aquila turrita appuntata sulla divisa; mentre all’orizzonte, un’altra donna per trovare… stimoli eccezionali.
“Cleared for landing”, eccoci in finale. El ciccio o, el bocia, a seconda di come mi va di chiamarlo che, tranne ovviamente gli omissis, conosce ormai tutto della mia vita; aspetta sempre quella frazione di secondo nella quale giro il capo a destra in cerca del “bosco” e della “vietta”, per lanciarmi la classica occhiata da presa per il culo. E’ colpa mia, gli ho fatto una testa grande come una mongolfiera a son di parlargli di questi due posti cari alla mia giovinezza. Sono pressoché convinto che questi due luoghi, a me ameni, siano ormai sulla bocca di tutti gli abitanti di Dalston; quel minuscolo e umido villaggio del North West dove, el ciccio risiede quando, non viene a scaldarsi le ossa qui a Venezia. Ho le prove che, non sapendo cosa fare tutto il giorno, in quello sparuto gruppetto di casette in meso ai glebani, come si dice dalle mie parti; passava il tempo a sputtanarmi nei pub; perché, quell’unica volta che è riuscito a trascinarmi a casa sua, gli indigeni del posto mi guardavano in modo strano, mettendosi a ridere di nascosto.
“Please contact ground at 121.7” siamo a terra, ormai è finita. Riesco a percepire quel coro di clack clack provocato dal liberatorio slacciarsi di cinture; pensare che devo ancora imboccare il raccordo per la taxiway. Li capisco, molti di loro staranno tirando un sospiro di sollievo, pronti a fuggire da quel cilindro metallico, costretti a stare seduti per ore, con la loro vita in mano a due tizi in cabina di pilotaggio; sperando inoltre che, nessuno dei due, si metta a far el mona. Io invece oggi, non mi muoverei più da questo sedile, settembre 1983, luglio 2019, trentasei anni con le ali addosso; è dura alzarsi da quel posto per l’ultima volta; io e el fio de anema evitiamo di incrociaci con lo sguardo, c’è il serio rischio che ci scappi la lacrima. Metto i documenti nel borsone, ho le mani sudate, non mi era mai capitato; esco frettolosamente dal cockpit senza voltarmi indietro. Scopro che a sorpresa le fie però hanno fatto l’annuncio ai passeggeri e, non appena metto la testa fuori, scoppia un applauso scrosciante. Fortunatamente, a causa della situazione non ci si può abbracciare; avrei pianto come un bambino. Un groppo in gola mi fa a malapena balbettare qualche parola in uno stentato inglese, quasi fossi regredito ai tempi delle scuole medie. Mi fanno tenerezza, povere ragazze, anche per loro i tempi sono cambiati; costrette, tra un volo e l’altro a pulire i sedili e sistemare le toilette per poi, frettolosamente, posarsi sulle ginocchia una vaschetta con il bollino, “meal deal 30% off”, che contraddistingue un insalata prossima alla scadenza.
Negli uffici operativi, al contrario, non c’è nessuna manifestazione di affetto; una ragazzina mai vista finora, probabilmente una neo assunta, senza nemmeno presentarsi, mi chiede il badge, nell’altra mano ha una busta pronta per la spedizione. Mi chiede inoltre che accordi ho riguardo la restituzione della divisa; ribatto che, se mi lascia le scarpe, posso uscire in mutande e canottiera, tanto fuori fa maledettamente caldo; arrossisce di colpo, mi sembra chiaro che sto scherzando.
Come un normale passeggero, mi avvio al nastro riconsegna bagagli, per la prima volta, mi prende l’ansia che non arrivino. Mamma che bolgia; ci sono centinaia di colli allungati e occhi puntati sulle porte scorrevoli che aspettano l’uscita di qualcuno; almeno oggi mi piacerebbe che ci fosse una sorta di comitato d’accoglienza per festeggiarmi invece, sono solo e frastornato da ‘sto gran vociare; che casino. Appena fuori, una folata di caldo umido, un nodo alla gola e, la saliva che non va ne su ne giù; per un attimo resto immobile, inebetito, non so che direzione prendere, mi ci vuole un buon quarto d’ora per ricordarmi dove avevo parcheggiato l’auto.
Dentro è peggio di un forno, così aspetto prima di salirci; istintivamente volgo lo sguardo verso l’aerostazione, giusto nel momento in cui il mio aereo sbuca dal tetto e punta nuovamente verso il cielo; osservo la manica della mia giacca distesa, come morta, sul sedile posteriore, quattro strisce e una stella, quanti sacrifici, e ora? “Intanto, torniamo a casa”, dissi tra me e me.
La casa; per i marinai, e anche per noi aviatori, rappresenta un qualcosa con cui abbiamo un rapporto particolare o, quantomeno diverso dalla gente di terra; così, mi trovai a ripassare mentalmente, l’ordine cronologico delle case dove sono vissuto e tutta quella serie di ex ad esse collegate; ex bambino, ex studente, ex moglie, ex famiglia e, via discorrendo; alla fine, mi è rimasta unicamente la ex casa dei nonni, quella del mitico “bosco”. Per accaparrarmela c’è voluto un notevole sforzo economico; sborsai un prezzo molto superiore al suo reale valore ma, era la condizione necessaria per liquidare mio padre e i relativi fratelli, mettendo la parola fine a anni di furibondi litigi sulla spartizione dei beni del vecchio nonno Rino.
La brusca sterzata a destra, per immettermi sulla stradina, lasciando la trafficata circonvallazione, è simile alla manovra di uscita dalla pista di Istrana. Questo però, non è il raccordo che mi porta all’hangar del 122° Gruppo ma, due polverose strisce di terra battuta frammezzate da una di erba bella alta. Non ho mai capito perché questo posto veniva chiamato “il bosco”, che mi ricordi, a parte il forte militare, non è che ci siano mai state grandi zone alberate, solo la tipica piattissima e infinita campagna veneta.
Non mi sarei mai aspettato di vederlo li, in mezzo all’orto, sotto quella cappa di piombo infernale, la cosa mi rese felice perché, Tiziano era proprio la persona che volevo incontrare;
“Direttor ..”
“Direttor de ‘sto casso. Comandante i miei ossequi ..”
“Ex comandante prego ..”
“Ma no! Spiega”
“Da ancuo in tera, finia!”
“Orpo! Pena ricomissià, cossa ti ga combinà?”
“’Sta situassion de merda”
“Mah, no xè che i ga vossuo trovar ‘na scusa par cassarte fora”
“Podaria essar”
“E ‘desso cossa ti fa?”
“No eo so ..”
“Intanto bevemoghe ‘na birretta sora”
Il mio amico era attrezzatissimo, dentro la vecchia baracca, teneva una borsetta frigo ben fornita; tanto da offrirmi la scelta del tipo di birra. La camicia della divisa, mi si era ormai appiccicata addosso ma, non appena feci cenno di andarmene verso casa per cambiarmi, mi strattonò per il braccio; “go ‘na idea”, disse tutto eccitato. In una manciata di secondi mi trovai a posare davanti le piante di pomodoro, con addosso la mitica giacca quattro strisce e una stella, ben in vista e, una vanga in mano. Titolo dell’inquadratura: “dal cielo alla terra; il ritorno”; stavo per mandarlo a cagare ma, la cosa iniziò a divertirmi tanto che gli sottoposi la mia idea. Improvvisammo uno spogliarello in mezzo ai campi per scambiarci gli abiti e farci delle foto.
Cenai abbastanza presto con le verdure che Tiziano mi aveva lasciato; avrei voluto invitarlo a farci una pizza assieme, mi avrebbe fatto un enorme piacere nonché risollevato il morale che giaceva sotto i tacchi ma lui, era già silenziosamente sparito in sella alla sua bicicletta. D’altronde, ultimamente, è sempre stato così, arrivava e spariva in punta di piedi e poi, non credo avrebbe mai accettato l’invito.
Per descriverlo, bastava il soprannome che gli aveva affibbiato mio nonno; “El tegoina rosso”. E’ sempre stato magro da far paura, pesavano più i suoi ricci capelli rossi che tutto il resto, le lentiggini gli davano solo in apparenza un aria furbetta, in realtà, era alquanto introverso. Non credo di aver mai conosciuto una persona più diffidente di lui; ricordo che, quando eravamo bambini, prima di rivolgermi la parola, andò avanti per parecchio tempo a osservarmi di nascosto attraverso le maglie della recinzione che divideva le nostre due case.
La passione per gli aerei, a me e Fabietto, c’è l’ha appiccicata lui; l’unico, ironia del destino, a non essere diventato pilota. Il destino, inoltre, volle che, oltre a essere vicini di casa, lo fossero pure le nostre “dependance” di campagna; ed è qui, che d’estate, in mezzo all’orto di suo papà, abbiamo letteralmente coltivato la nostra passione aviatoria. Ci portavamo da casa i modellini di aerei costruiti nei mesi invernali; le strisce di terra battuta tra le gombìne erano le nostre piste mentre, la baracca dove sior Gino, suo papà, teneva gli attrezzi, il nostro hangar. La mia flotta, credo anche per le mie possibilità economiche, era molto più numerosa e strategicamente più evoluta della sua; potevo contare sui più possenti e avanzati jet da combattimento mentre, quel povero sfigato di Tiziano, si ritrovava, per la maggior parte, con dei vecchi rosegoti a elica della II^ guerra mondiale.
A sior Gino, “l’omo de ‘egno”, come lo chiamava mio nonno, a causa della sua durezza d’animo, non andava affatto che ci divertissimo a giocare in mezzo al suo preziosissimo orto; mi fece capire chiaramente che, Tiziano, non era li per trastullarsi tutto il giorno come me, ma, per dare una mano all’economia familiare, per altro, ci tenne a sottolineare, ben più misera rispetto a quella della mia famiglia.
Un giorno per aver utilizzato inavvertitamente, come territorio di sorvolo ed esercitazione la gombìna con i bisi appena seminati si infuriò come una belva; prese a botte prima Tiziano e poi me. Oggi la cosa sarebbe finita sui giornali; a quel tempo, invece, sancì semplicemente la fine dei rapporti tra le nostre famiglie. Io e Tiziano, perdemmo il nostro fantastico aeroporto e, da quel giorno, continuammo a vederci quasi clandestinamente.
Il bello dell’estate è che dopo cena, puoi fare ancora un sacco di cose. Inforcai la vecchia Bianchi del nonno per farmi un giro giro rinfrescante, prima attorno al forte poi, in direzione del bosco Ottolenghi, per finire a godermi il tramonto, sulla panchina in riva al laghetto del bosco di Franca.
Sedermi su questa panchina è un rito che compio spesso, a fianco c’è un cartello che spiega la storia di Franca; fatta sparire a diciotto anni, durante la dittatura militare in Argentina. Il modo con cui la uccisero, ovvero gettandola in mare da un aereo, i cosiddetti “voli della morte”; lascia, in un pilota come me, una rabbia e una incredulità profonda. Come era possibile che, un mio collega, si fosse prestato come esecutore di una simile atrocità? Ho sempre volato per passione, anche quand’ero pilota militare. Ero perfettamente conscio del fatto che pilotavo sostanzialmente un arma che, avrebbe potuto uccidere altre persone. Quando sono seduto su questa panchina, mi chiedo che differenza c’è tra dare l’ordine di scaraventare giù in mare una decina di persone incatenate e premere un bottone per sganciare una bomba. A me, fortunatamente, esercitazioni a parte, di premere il bottone non è mai capitato, ad altri, si.
Si è fatto scuro e il canto dei grilli si è sostituito a quello delle cicale, l’aguasso dei campi coltivati, rinfresca l’aria. Mentre percorro i trosi di campagna in sella a questa vecchia bici, torno quel bambino che sognava di volare e, si chiedeva continuamente se sarebbe riuscito a farlo. Non so cosa farò da domani ma, so sicuramente quello che non voglio fare, ovvero, starmene con i piedi per terra e vivere di ricordi; è ancora troppo presto.
Penso a Tiziano, il suo sogno stroncato da una famiglia che, sin da piccolo, l’ha oppresso succhiandogli il sangue; non abbiamo mai parlato delle nostre famiglie ma, ho l’impressione che le cose ora, non vadano tanto diversamente. E’ malinconico, si vede che vive soprattutto di sogni; quel “beato ti” che spesso gli sento dire, fa capire che incarno la persona che avrebbe voluto essere; rispecchio, come, in realtà, avrebbe voluto vivere. Scommetto che, in alcuni particolari momenti, gli avrebbe fatto comodo star seduto su un seggiolino eiettabile, tirare la cordicella gialla e nera, e via, sparire.
Siamo in tre seduti sulla mitica panchina in riva al canale che porta alla darsena dell’aeroporto; io, el fio de anema e Tiziano più, un frighetto con le birre; scrutiamo l’orizzonte, ora, per fortuna, sbucano spesso aerei.
“Cossa diria Fabietto ‘desso?”
“Che mi so stà mona a no diventar pilota, e che ti ti saressi cojon a no partir”
Lascio una copia di chiavi del “bosco” a entrambi; spero che Tiziano, oltre a occuparsi della casa e relativi terreni, dia al bocia delle buone verdure, al posto delle usuali schifezze che ingurgita e che, continui, come me, a insegnargli la nostra lingua natia; finora riesce a pronunciare decentemente solo ghesboro e mimorti. Ho fatto un bel discorsetto a Harry; gli ho detto di portare il massimo rispetto allo zio Tiziano perché, anche se non è diventato pilota, è comunque uno di noi; un aviatore nell’anima.
A Veléz la pista è piccola ma, come recitava la pubblicità di un piccolo jet, “una strada di un kilometro non porta da nessuna parte, una pista di un kilometro in tutto il mondo”. Vedrò la polvere rossastra mossa dalle eliche; godrò dei tantissimi giorni di sole, ottimi per volare, per insegnare, ai miei futuri fioi de anema, a volare rasenti la superficie del mare.
Solo l’idea di una nuova emozione, nessuna spinta, nemmeno quella dell’F104 in decollo, è più impetuosa di un pensiero che cresce di tono e che travolge ogni cosa che pensi. Sento che torneranno i giorni di Los Genoveses; sentirò nuovamente il suo profumo, la sola forma di fedeltà che si concede; porta aperta sul meraviglioso, un frammento d’anima.
La birra gelata scende, alla tua salute Fabietto … è ora di andare
_________
“Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. Qualunque cosa tu faccia non pensare mai a cosa diranno gli altri, segui solo te stesso, perché solo tu nel tuo piccolo sai cosa è bene e cosa è male, ognuno ha un proprio punto di vista, non dimenticarlo mai, impara a distinguerti, a uscire dalla massa, non permettere mai a nessuno di catalogarti come “clone di qualcun’altro”, sei speciale perché sei unico, non dimenticarlo mai. Non dar retta ai tuoi occhi e non credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda col tuo intelletto, e scopri quello che conosci già, allora imparerai come si vola.”
Richard Bach
____________
Racconto tratto dalla raccolta CAMPARE IN ARIA – © 2021 Michele Camillo
Ultime pubblicazioni
Indice Racconti